Vi presentiamo il sesto racconto del progetto Cuentos guatemaltecos, in collaborazione con il Professor Stefano Tedeschi e il Dipartimento di Studi Europei Americani e Interculturali dell'Università La Sapienza, per cui pubblicheremo nove racconti di autori guatemaltechi contemporanei, in versione spagnola e italiana, tradotti dagli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione. È un’occasione per conoscere una narrativa viva e ricca che si manifesta nelle forme più varie del racconto.
 Aída Toledo nasce a Città del Guatemala, nel 1952. Scrittrice di narrativa, ma soprattutto poetessa, si avvicina alla letteratura e alla scrittura grazie all’università. Nel 1985 si laurea in Letteratura all’Università San Carlos di Guatemala e, alcuni anni dopo, si trasferisce negli Stati Uniti dove frequenta l’Università di Pittsburgh, conseguendo un master nel 1997 e un dottorato nel 2001. In quello stesso anno, pubblica la sua prima antologia di racconti, Pezóculos, seguito da Como en historia de Faulkner (2015) e El mundo es todo lo que acaece (2018), da cui è tratto il seguente racconto. In realtà, la sua attività di scrittrice si concentra principalmente sulla poesia, infatti, pubblica varie raccolte, fra cui Brutal batalla de silencios (1990), Realidad más extraña que los sueños (1994), Bondades de la cibernética (1998), Con la lengua pegada al paladar (2006), Nada que ver (2012). I temi affrontati nelle sue opere, narrati con uno stile semplice, ma personale, si ispirano a fatti realmente accaduti o alle diverse realtà in cui ha vissuto l’autrice. Inoltre, i suoi lavori hanno ricevuto diversi premi e sono stati tradotti in varie lingue, tra cui il kaqchikel. Attualmente è docente all’Università Rafael Landívar del Guatemala e continua a scrivere.
Aída Toledo nasce a Città del Guatemala, nel 1952. Scrittrice di narrativa, ma soprattutto poetessa, si avvicina alla letteratura e alla scrittura grazie all’università. Nel 1985 si laurea in Letteratura all’Università San Carlos di Guatemala e, alcuni anni dopo, si trasferisce negli Stati Uniti dove frequenta l’Università di Pittsburgh, conseguendo un master nel 1997 e un dottorato nel 2001. In quello stesso anno, pubblica la sua prima antologia di racconti, Pezóculos, seguito da Como en historia de Faulkner (2015) e El mundo es todo lo que acaece (2018), da cui è tratto il seguente racconto. In realtà, la sua attività di scrittrice si concentra principalmente sulla poesia, infatti, pubblica varie raccolte, fra cui Brutal batalla de silencios (1990), Realidad más extraña que los sueños (1994), Bondades de la cibernética (1998), Con la lengua pegada al paladar (2006), Nada que ver (2012). I temi affrontati nelle sue opere, narrati con uno stile semplice, ma personale, si ispirano a fatti realmente accaduti o alle diverse realtà in cui ha vissuto l’autrice. Inoltre, i suoi lavori hanno ricevuto diversi premi e sono stati tradotti in varie lingue, tra cui il kaqchikel. Attualmente è docente all’Università Rafael Landívar del Guatemala e continua a scrivere.
Buon compleanno!
di Aída Toledo
traduzione di Elisa Capannolo
Emilia e la sua amica nordamericana vennero a prendermi verso le otto di sera. Quel giorno era il mio compleanno, e loro avevano deciso di portarmi a una sala da ballo chiamata Cozumel, dove si ballava la salsa e ci si poteva divertire per qualche ora. Mia figlia era rimasta con mia mamma, che per fortuna in quei giorni era venuta a trovarmi. Io mi vestii di nero, come sempre. Portavo un paio di pantaloni morbidi, una camicetta nera scollata, e un maglione di quelli in velluto a coste, un po’ eleganti, ma allo stesso tempo informali. Mi sentivo bene, perché almeno per qualche ora potevo uscire a divertirmi, dopo aver lavorato alla correzione di centinaia di compiti dove quello che meno appariva era la lingua spagnola. Per prima cosa andammo a prenderci una birra e a spizzicare dei nachos in un ristorante, vicino al Cozumel, per caricarci (secondo Emilia) per poter ballare tutta la notte.
Lei sì che aveva molta esperienza in questo tipo di uscite del fine settimana. Io invece avevo smesso di ballare da molti anni, e mi faceva strano dover andare in un locale per trovare qualcuno, senza impegno. Per questo motivo, quando arrivammo alla sala da ballo mi sentii stranissima. A Emilia chiesero subito di ballare perché era di casa, e in più era di una bellezza particolare e aveva un bel carattere. La sua amica ed io la osservavamo contente di essere lì, godendoci i momenti di totale relax, chiacchieravamo e bevevamo acqua o Coca Cola, non ricordo. All’improvviso, vidi arrivare verso di me un uomo sui trentacinque anni, vestito in modo informale ma con un aspetto pulito, uno sguardo buono e ben pettinato (così mi sembrò in mezzo al fumo, alle luci e a tutto ciò che c’è in una sala da ballo alle undici di sera). Do you want to dance? mi chiese. Io sul momento non ci pensai due volte, e senza rispondergli gli diedi la mano; mi prese dolcemente, per poi cominciare a ballare. Da vicino potei guardarlo meglio, e mi faceva un po’ strano ballare con un nordamericano che sembrava un artista dei film di oggi. Era alto, magro, bianco, dal bel profilo e dalla fronte alta, aveva i capelli lisci e castani e profumava di pulito. Portava dei pantaloni color cachi, una camicia beige e una giacca azzurra abbinata al resto dell’abbigliamento. Non gli sudavano le mani, eppure sembrava leggermente nervoso, il che mi fece pensare che non aveva così tanta esperienza nel rimorchiare nelle sale da ballo d’estate, in quell’anno già abbastanza svanito nei miei ricordi. What’s your name? mi chiese. E io gli dissi che mi chiamavo Isidora. Ah, mi disse, where are you from? al che gli risposi con una bugia grossa come una casa. Ad ogni modo, oggi credo che non avrebbe saputo distinguere tra Costa Rica, Colombia o Guatemala. Era la stessa cosa. Per lui ero una donna latinoamericana, che doveva saper ballare la salsa, e per questo mi aveva invitata. All’inizio volle sondare il terreno, ma io lo allontanavo con eleganza, non gli permettevo di avvicinarsi molto. Mi ricordai che per i gringos lo spazio privato è inviolabile, e che se uno di loro vuole avvicinarsi, basta prendere le distanze per fargli capire che non può. Quando capì che non c’era verso di ballare cheek to cheek, mi invitò a prendere qualcosa da bere, ovviamente ordinai un’altra Coca Cola, e non volli per nessuna ragione dell’alcol. Lui, invece, chiese una birra Miller e se la bevve lentamente. Lo vedevo che mi osservava con la coda dell’occhio, mentre facevo finta di cercare qualcosa nel portafoglio. Poi mi sorrideva di nuovo senza sapere bene di cosa parlare o di quali temi conversare.
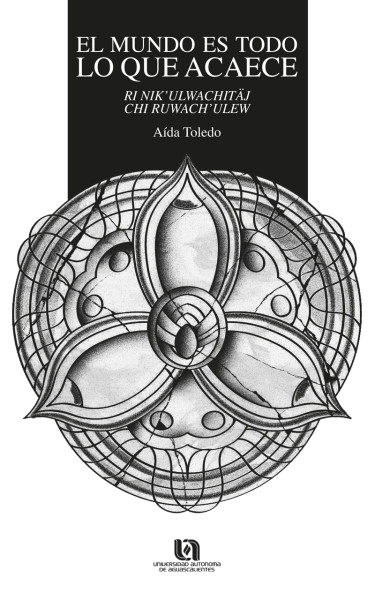 All’improvviso gli venne in mente di chiedermi cosa facessi nel suo paese, e io risposi prontamente che ero una studentessa. Il suo viso mostrò immediatamente una certa sorpresa e un po’ di scetticismo, allora aggiunsi: sono una studentessa laureata iscritta al programma di spagnolo dell’Università, e glielo dissi agevolmente in un inglese con un forte accento dello spagnolo del mio paese. Ah, disse. Allora vieni spesso in questo posto con le tue amiche. Per cambiare argomento, gli chiesi cosa facesse lui, e rispose che era ingegnere e costruiva case. Si era laureato a Philadelphia circa quattro anni prima. In quel momento lavorava per una ditta che costruiva palazzi in diverse parti della città in cui vivevo. All’inizio la sua storia mi sembrò vera. Però poi, vedendolo conversare con me con tanto interesse, senza conoscerci, senza che nessuno ci avesse presentati, così all’improvviso, iniziai a pensare che fosse proprio lui il regalo di cui Emilia mi aveva parlato e che mi avrebbero dato più tardi durante la serata. Per questo gli chiesi se conoscesse le mie amiche. Lui, sorpreso, mi rispose di no, che era la prima volta che le vedeva. E mi chiese se anche loro fossero studentesse. Io risposi di sì. Ah, bene, disse, allora venite spesso a divertirvi qui il fine settimana, perché mettono sempre la salsa. Ma gli spiegai che era la prima volta in tre anni, ossia da quando vivevo in città, che avevo l’opportunità di uscire, perché avevo una bambina piccola. Contrariamente alle aspettative, non mi chiese se fossi sposata o impegnata, e io pensai che non lo fece perché era il mio regalo di compleanno. Le mie amiche avevano pagato un gigolò perché trascorressi una bella serata, rendendo questo giorno per me indimenticabile. Così mi aveva detto Emilia, vogliamo che questa serata sia indimenticabile, ed effettivamente non potevo lamentarmi. Perché Mike, così si chiamava il gringo, era molto piacevole, e non sembrava annoiarsi con me, o quantomeno stava facendo molto bene il suo lavoro. In quel momento, non riuscivo neanche ad immaginare come si possano pagare dei ragazzi per questo tipo di cose. Ma in realtà, per cosa non si può pagare o cosa non si può ottenere in questo paese, mi chiesi varie volte ricordando i miei sette lunghi anni d’esperienza in questa città finta. Restammo seduti al tavolo a conversare; nel frattempo, Emilia e l’altra ragazza ballavano con diversi uomini, molto contente, ridevano e volteggiavano, sfoggiando le loro abilità nei balli latinoamericani. Allora Mike, che non mi sentiva bene per l’eccessivo baccano, mi chiese di uscire un momento, per fumare e prendere una boccata d’aria. A me sembrò strano, ma pensai che non avevo niente da temere, visto che si era comportato quasi tutto il tempo da vero gentiluomo. Allora uscimmo davanti al Cozumel, appoggiati a dei pali della luce dove la gente del posto usciva a fumare e chiacchierare. Allora, mi disse, mi stavi dicendo che tra poco tornerai al tuo paese? Sì, gli dissi. Sto via per due mesi, ma poi torno. Per la prima volta Mike mi guardò più intensamente, senza più quel modo nordamericano di guardare senza guardare, e mi disse che voleva dirmi qualcosa. In quel momento riuscii a vedere i suoi occhi, che con l’intensità delle luci della strada risaltavano: erano di un verde scuro, un po’ muschioso, con pagliuzze color caffè intorno. Mi diede il suo biglietto da visita che diceva a chiare lettere: Michael Pfizer, con numeri di telefono, email, indirizzo, cercapersone, eccetera, e mi chiese un numero per potermi chiamare al termine dei due mesi, ma gli dissi formalmente che lo avrei chiamato io al mio ritorno, per uscire o qualcosa del genere. In fondo sapevo che sarebbe finito tutto lì, perché lui continuava a far finta che il nostro incontro al Cozumel e il fatto che mi avesse invitata a ballare fosse stato tutto una casualità. Tristemente, sapevo che lui era la mia elemosina, che lo avevano pagato perché mi divertissi tutta la serata, non corressi rischi, e mi ricordassi per sempre di quel ballo, lì, nella southside della città che mi aveva già dato tanto. Ed ora questo. Un ragazzo perfetto con cui ballare, chiacchierare, senza che mi succedesse qualcosa di brutto, protetta da ogni pericolo. Tornammo dentro e trovammo Emilia e le sue amiche già sedute al tavolo che mi stavano aspettando. Tutto bene? mi chiese Emilia. Risposi di sì, stavo quasi per ringraziarla ma non lo feci, per non sembrare poco professionale. Lo presentai a tutti i presenti, che lo salutarono chiedendogli come si chiamasse, quando sapevo che Emilia e l’altra già conoscevano almeno il suo nome. Ma cercavano di dissimulare perché non mi accorgessi di niente, perché gli altri non notassero che quel ragazzo era in realtà il mio regalo. Mike si sedette di nuovo vicino a me, e continuò a parlarmi del suo lavoro, della casa che stava costruendo, mi disse che mi sarebbe piaciuta quando mi avrebbe portato a vederla, che sarebbe stato molto contento se avessi accettato di andare a dargli la mia opinione. Emilia mi guardava con la coda dell’occhio, io le lanciavo degli sguardi riconoscenti per quella bella serata piacevole.
All’improvviso gli venne in mente di chiedermi cosa facessi nel suo paese, e io risposi prontamente che ero una studentessa. Il suo viso mostrò immediatamente una certa sorpresa e un po’ di scetticismo, allora aggiunsi: sono una studentessa laureata iscritta al programma di spagnolo dell’Università, e glielo dissi agevolmente in un inglese con un forte accento dello spagnolo del mio paese. Ah, disse. Allora vieni spesso in questo posto con le tue amiche. Per cambiare argomento, gli chiesi cosa facesse lui, e rispose che era ingegnere e costruiva case. Si era laureato a Philadelphia circa quattro anni prima. In quel momento lavorava per una ditta che costruiva palazzi in diverse parti della città in cui vivevo. All’inizio la sua storia mi sembrò vera. Però poi, vedendolo conversare con me con tanto interesse, senza conoscerci, senza che nessuno ci avesse presentati, così all’improvviso, iniziai a pensare che fosse proprio lui il regalo di cui Emilia mi aveva parlato e che mi avrebbero dato più tardi durante la serata. Per questo gli chiesi se conoscesse le mie amiche. Lui, sorpreso, mi rispose di no, che era la prima volta che le vedeva. E mi chiese se anche loro fossero studentesse. Io risposi di sì. Ah, bene, disse, allora venite spesso a divertirvi qui il fine settimana, perché mettono sempre la salsa. Ma gli spiegai che era la prima volta in tre anni, ossia da quando vivevo in città, che avevo l’opportunità di uscire, perché avevo una bambina piccola. Contrariamente alle aspettative, non mi chiese se fossi sposata o impegnata, e io pensai che non lo fece perché era il mio regalo di compleanno. Le mie amiche avevano pagato un gigolò perché trascorressi una bella serata, rendendo questo giorno per me indimenticabile. Così mi aveva detto Emilia, vogliamo che questa serata sia indimenticabile, ed effettivamente non potevo lamentarmi. Perché Mike, così si chiamava il gringo, era molto piacevole, e non sembrava annoiarsi con me, o quantomeno stava facendo molto bene il suo lavoro. In quel momento, non riuscivo neanche ad immaginare come si possano pagare dei ragazzi per questo tipo di cose. Ma in realtà, per cosa non si può pagare o cosa non si può ottenere in questo paese, mi chiesi varie volte ricordando i miei sette lunghi anni d’esperienza in questa città finta. Restammo seduti al tavolo a conversare; nel frattempo, Emilia e l’altra ragazza ballavano con diversi uomini, molto contente, ridevano e volteggiavano, sfoggiando le loro abilità nei balli latinoamericani. Allora Mike, che non mi sentiva bene per l’eccessivo baccano, mi chiese di uscire un momento, per fumare e prendere una boccata d’aria. A me sembrò strano, ma pensai che non avevo niente da temere, visto che si era comportato quasi tutto il tempo da vero gentiluomo. Allora uscimmo davanti al Cozumel, appoggiati a dei pali della luce dove la gente del posto usciva a fumare e chiacchierare. Allora, mi disse, mi stavi dicendo che tra poco tornerai al tuo paese? Sì, gli dissi. Sto via per due mesi, ma poi torno. Per la prima volta Mike mi guardò più intensamente, senza più quel modo nordamericano di guardare senza guardare, e mi disse che voleva dirmi qualcosa. In quel momento riuscii a vedere i suoi occhi, che con l’intensità delle luci della strada risaltavano: erano di un verde scuro, un po’ muschioso, con pagliuzze color caffè intorno. Mi diede il suo biglietto da visita che diceva a chiare lettere: Michael Pfizer, con numeri di telefono, email, indirizzo, cercapersone, eccetera, e mi chiese un numero per potermi chiamare al termine dei due mesi, ma gli dissi formalmente che lo avrei chiamato io al mio ritorno, per uscire o qualcosa del genere. In fondo sapevo che sarebbe finito tutto lì, perché lui continuava a far finta che il nostro incontro al Cozumel e il fatto che mi avesse invitata a ballare fosse stato tutto una casualità. Tristemente, sapevo che lui era la mia elemosina, che lo avevano pagato perché mi divertissi tutta la serata, non corressi rischi, e mi ricordassi per sempre di quel ballo, lì, nella southside della città che mi aveva già dato tanto. Ed ora questo. Un ragazzo perfetto con cui ballare, chiacchierare, senza che mi succedesse qualcosa di brutto, protetta da ogni pericolo. Tornammo dentro e trovammo Emilia e le sue amiche già sedute al tavolo che mi stavano aspettando. Tutto bene? mi chiese Emilia. Risposi di sì, stavo quasi per ringraziarla ma non lo feci, per non sembrare poco professionale. Lo presentai a tutti i presenti, che lo salutarono chiedendogli come si chiamasse, quando sapevo che Emilia e l’altra già conoscevano almeno il suo nome. Ma cercavano di dissimulare perché non mi accorgessi di niente, perché gli altri non notassero che quel ragazzo era in realtà il mio regalo. Mike si sedette di nuovo vicino a me, e continuò a parlarmi del suo lavoro, della casa che stava costruendo, mi disse che mi sarebbe piaciuta quando mi avrebbe portato a vederla, che sarebbe stato molto contento se avessi accettato di andare a dargli la mia opinione. Emilia mi guardava con la coda dell’occhio, io le lanciavo degli sguardi riconoscenti per quella bella serata piacevole.
Il Cozumel stava per chiudere, erano quasi le tre del mattino e il tempo era volato chiacchierando, ridendo, scherzando in una lingua che rispetto ad oggi padroneggiavo con molta più fatica. Alla fine, Mike mi salutò e mi guardò con aria seria. Non dimenticarti, mi disse, che hai il mio biglietto da visita. Divertiti nel tuo paese, saluti alla tua famiglia. E io lo ringraziai, dicendogli che, sì, mi sarei sicuramente divertita.
Mentre ci dirigevamo verso l’altra parte della città, le ragazze, che erano felici e soddisfatte, mi dissero, ora sì che puoi aprire il regalo! e mi diedero una grande scatola che conteneva una giacca invernale molto bella. Ma cos’è questa, dissi, pensavo che il mio regalo fosse Mike! Ma seriamente? esclamò Emilia, io pensavo che fosse un tuo amico. E io, che avevo lasciato cadere fuori dal finestrino della macchina i pezzetti in cui avevo ridotto il biglietto da visita che il gringo mi aveva dato, versai delle lacrime lente, non appena mi resi conto che non sempre le giacche invernali sono il miglior regalo.
© Aída Toledo, 2018. Tutti i diritti riservati.




